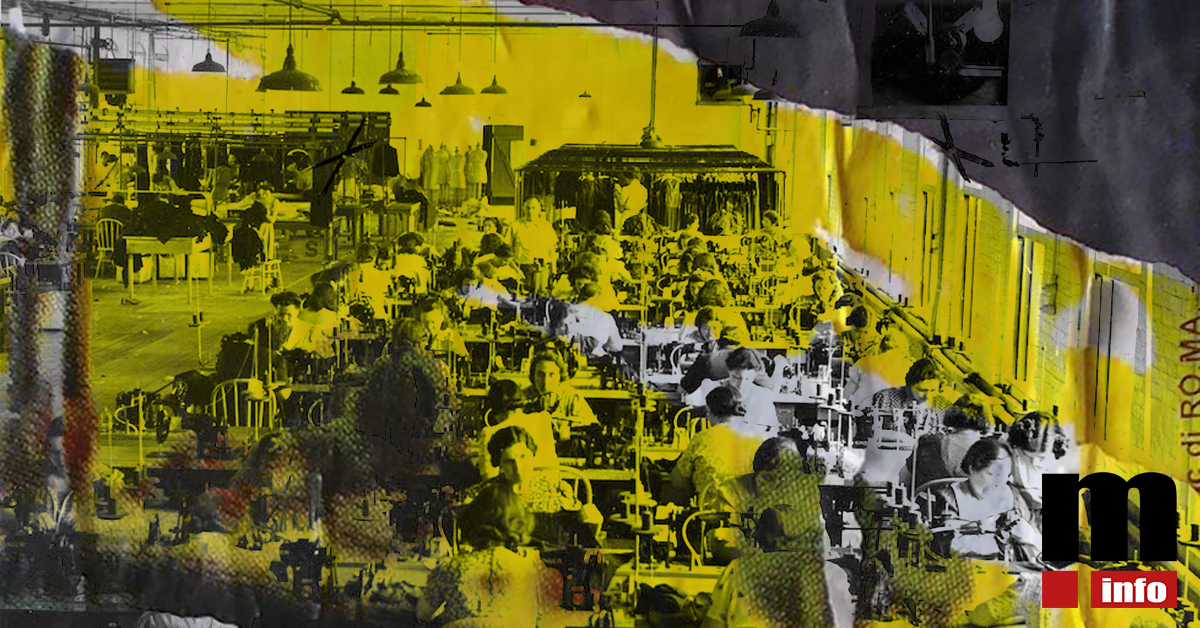Continuiamo il nostro lavoro di analisi sul lavoro pubblicando la seconda parte di Lavoro, reddito e benessere materiale. La prima parte è disponibile qui.
Il processo di integrazione globale è un processo scomodo da maneggiare, perché poco chiaro nelle sue propaggini socio-economiche; scomodo perché pieno di contraddizioni, scomodo perché si basa su strumenti assai potenti che lasciano il segno e influenzano enormemente i territori su cui operano.
Il processo di integrazione globale è altrettanto scomodo per gli stessi soggetti che ne fanno uso, nel momento in cui si trovano ad armeggiare un processo molto flessibile e rapido che con la stessa velocità con la quale riesce a far schizzare il PIL in una regione, ne affossa un’altra. Non è quindi semplice decifrare il senso del lavoro nella nostra contemporaneità senza comprendere fino in fondo cos’è il processo di globalizzazione e quali sono gli scenari che ha contribuito a chiudere e quali quelli che invece sta aprendo.
Il lavoro e la struttura economica sono molto più che fattori interdipendenti, sono elementi costitutivi dello stesso sistema che, pur essendo influenzati dai medesimi processi, assumono ruoli diversi all’interno del meccanismo di riproduzione del capitale. Le relazioni che legano il lavoro alla struttura economica della società contemporanea prevedono che il lavoro debba essere identificato e catalogato per poter essere inteso e per comprenderne il ruolo all’interno dei processi produttivi. L’avanzamento tecnologico aumenta la velocità di trasferimento dei servizi delle risorse e del capitale, fino al punto in cui i flussi di investimento e i trasferimenti di denaro sono praticamente istantanei e virtualmente senza confini; mentre la velocità di trasferimento della forza lavoro oltre a essere dettata dai tempi di trasporto è limitata dai confini istituzionali. Da un lato, i servizi e le merci non conoscono (o quasi) barriere; dall’altro, il lavoro è bloccato e territorialmente circoscritto (Stiglitz, 2015).
L’innovazione tecnologica crea le condizioni sulle quali si costruiscono nuovi scenari e sulle quali sono impostate le istanze di cambiamento della struttura socio economica mondiale. L’implementazione del sistema dei trasporti e dell’informatizzazione della logistica ha contribuito in maniera assai profonda alla ridefinizione di tempi e costi attraverso un processo di efficientamento a livello mondiale. Ciò ha favorito la delocalizzazione della produzione in aree nelle quali il costo del lavoro è concorrenziale, addirittura con l’avanzamento tecnologico, nel momento in cui il lavoro umano costa poche decine di dollari al mese. Ma, al di là di alcune eccezioni, il processo congiunto di delocalizzazione e automazione sta rendendo problematica la gestione delle residualità di lavoratori attualmente impegnati in Europa e Stati Uniti. Per questi lavoratori l’economia neoliberista non è in grado di trovare una collocazione, se non chiedendo programmi statali di accompagnamento dolce alla disoccupazione.
È il caso della FCA che, non avendo più bisogno di lavoratori tra Pomigliano e Melfi, procede a ristrutturazioni della produzione, lasciando a casa gente problematica e trattenendo (chissà per quanto ancora) lavoratori più mansueti. Quindi abbiamo, da un versante, lavori che tendono a sparire perché semplicemente sono rimpiazzati o dalle macchine o da esseri umani che costano meno, mentre, dall’altro, quel poco che resta è spinto dal principio di massimizzazione della produttività. Dal momento che un lavoratore in Europa “costa troppo”, allora devo farlo lavorare più intensamente nelle 8 ore, solo così posso parzialmente bilanciare lo svantaggio competitivo di lasciare la produzione in Italia.
Il meccanismo che si produce è il seguente: si riduce il personale e quello che resta viene sottoposto a ritmi molto intensi e usuranti, chi perde il lavoro (soprannumerario o semplice contestatore del ritmo produttivo) lotta per essere riassunto in un posto di lavoro parimenti logorante o comunque destinato a sparire, per opera della delocalizzazione o per opera dell’automazione.
Precedentemente si è data una sommaria spiegazione del significato del salario in epoca fordista e delle sue mutazioni in epoca post-fordista. Il passaggio dal salario dell’operaio al reddito generale dei vari strati della società non è un’operazione lineare. In questo passaggio logico è racchiusa, in parte, la ratio che denota il cambiamento fondamentale introdotto nell’economia dagli Ottanta in poi. Ciò che è avvenuto è riassumibile nel concetto espresso da due economisti, Grossman e Rossi-Hansberg, che nel 2006 con un articolo dal titolo The rise of offshoring: it’s not wine for cloth anymore, introducevano nel dibattito economico mondiale la spiegazione di un cambio di paradigma assai profondo che mandava in soffitta le teorie del valore (per quanto concerne l’economia politica) di Smith e Ricardo. Nel momento in cui il vantaggio competitivo della delocalizzazione rende più conveniente produrre qualcosa altrove, non c’è più una specializzazione nazionale (la Germania esportava carbone in Inghilterra e da questa importava cotone).
Semplificando, l’attuale impalcatura dell’economia mondiale si basa su alcuni punti cardine: si ricolloca la produzione dove l’abbattimento dei costi rende l’operazione più competitiva, aumentando i profitti; si cercano altri mercati in via d’espansione per collocarvi il grosso della produzione; si mantiene una rete di servizi distributivi nei propri confini nazionali in quanto il grosso della produzione di beni è stata delocalizzata, mantenendo in loco il minimo indispensabile per poter continuare a usare il made in (Italy, USA, Germany, ecc.). Nell società dei consumi è chiaro a cosa possa servire il reddito, ma qui si apre un altro punto critico di discussione, se non addirittura un altro paradosso: nella società attuale, sorretta dal principio di crescita lineare, si tende a ridurre la capacità di spesa inibendo l’istanza di base su cui essa si fonda, ovvero il consumo a livello individuale. Posta in questo senso la questione appare paradossale, ma in realtà le cose non stanno esattamente così in quanto va chiarito un aspetto cruciale, ossia l’individuazione dell’elemento centrale che necessita della crescita lineare. A ben vedere la popolazione è parte di questo meccanismo, ma non gioca un ruolo fondamentale. Soprattutto in una fase nella quale si può creare profitto impegnando risorse offshore, oppure ridimensionando la forza lavoro e ampliando il “parco macchine”. Le macchine – e i mezzi più in generale – sono dunque sviluppati in un uso capitalistico ostile alla forza-lavoro (Alquati, 1994).
Cosa fare della forza lavoro inutilizzata? In economia non si butta via mai nulla; semmai, si immagazzina o si utilizza in altro modo. L’esercito industriale di riserva di marxiana memoria ha sempre svolto una precisa funzione sociale anche come strumento di ricatto sociale per ritardare la completa meccanizzazione della produzione. Si cerca quindi di mantenere in equilibrio il sistema per garantire un minimo di inerzia di moto, ma solo per semplici ragioni di stabilità sociale, in quanto le aziende vanno a cercare fortuna altrove, avendo sia la localizzazione ottimale, ove allocare risorse produttive, sia i compratori ottimali cui vendere. L’occidente non è più la terra dei consumi, pur rimanendo legata a questo concetto. I mercati più floridi sono a oriente, non solo India e Cina, ma in tutta quella porzione geografica cui spesso non si fa molto caso, come ad esempio i territori dell’Azerbaijan.
Che senso ha oggigiorno il lavoro salariato in occidente nel momento in cui si punta alla progressiva virtualizzazione della produzione (Tronti, 2009)? Se il lavoro umano salariato non è più la componente principale della riproduzione del capitale, come si riproduce la società dei consumi? La risposta non è semplice. L’analisi delle attuali tendenze del mercato del lavoro induce a immaginare lo sviluppo di una sorta di “operaio non manuale”, ossia di una figura professionale iper-specializzata in mansioni tecnico-pratiche o procedurali. Sono questi i casi della catena della logistica nella quale il facchinaggio è una componente numericamente bassa di tutta la forza lavoro impiegata, costituita in maggioranza da magazzinieri, tecnici meccanici o informatici che assistono e controllano le macchine.
Ma in tutto ciò viene introdotto anche un altro grosso cambiamento sociale: fino agli anni ’80 l’operaio era una figura con una sua valenza socio-economica, nel senso che il salario dell’operaio era la base minima su cui costruire la società dei consumi a livello nazionale. Il salario era la misura sociale della ricchezza: sotto un certo livello si era considerati poveri, su quel livello si faceva una vita “normale”. Superato il salario dell’operaio cominciava la borghesia agiata. Oggi quest’ordine non solo è mutato, ma non vi è più uno strato sociale di riferimento che faccia da soggetto mediano (Alquati, 1978) tra le due classe storiche di riferimento. Tutto è divenuto piuttosto relativo, soprattutto se l’analisi si limiti al solo possesso di strumenti tecnologici o dell’autovettura.
Il mercato ha reso disponibili e facilmente accessibili prodotti per tutte le categorie sociali. Il credito al consumo ha esteso le potenzialità del reddito oltre la sua misura, portando milioni di persone a familiarizzare con il concetto di debito. Nella società di oggi anche i poveri sono diversificabili in categorie; c’è il povero “sfortunato”, al quale la crisi ed eventi avversi hanno portato via tutto, e poi ci sono i poveri “sconvenenti”, il sottoproletariato urbano, costituito da migranti, minoranze etniche e soggetti marginalizzati. Questi sono i poveri per i quali non vi è una giustificazione in quanto, pur partecipando al generale processo riproduttivo della società capitalista, non sono accettati. Il ruolo del sottoproletariato urbano cruciale perché fornisce la spiegazione semplicistica per ogni sorta di problema.
Ma andiamo oltre. In chiave di relazione tra produzione e consumo, la base della piramide sociale fornisce due gradi di libertà alla libera riproduzione del capitale, da un lato, svincola fondi pubblici da immettere nel sistema del terzo settore che innesca circuiti di consumo assistito; dall’altro, tutto ciò che ha a che fare col sottoproletariato è quasi sempre di natura informale, compreso il lavoro, il quale viene adoperato in circuiti produttivi a basso costo.
Il senso del lavoro, come elemento di emancipazione sociale, ha finito per dimostrare la menzogna che è sempre stata. Il lavoro “emancipa” solo nella misura in cui si è liberi acquirenti ed “eleva” solo nella misura in cui l’individuo vorrebbe guadagnare di più per acquistare di più. In quest’ottica il fordismo è ancora presente come orizzonte di benessere economico cui tendere. Ma come fare a uscire dal vicolo cieco in cui versa attualmente l’occidente è un’incognita alla quale si deve prestare attenzione perché è su queste elaborazioni e su queste proposte che si giocano i futuri equilibri sociali o le strategie per ammansire gli individui.
Qui entra in gioco l’asso nella manica, la teoria legata ai redditi di cittadinanza o, in una visione ancora più “estrema”, al basic income: redditi monetari elargiti dallo Stato e prelevati attraverso dei meccanismi fiscali, atti a compensare il fatto che (almeno in occidente) il concetto di lavoro umano sta progressivamente abbandonando il campo. In molti ci vedono il compimento di una società libera e felice, altri il compimento della supremazia dello Stato, altri ancora una schiavitù senza catene, ecc.
A parte la differenziazione tra i redditi derivanti dal workfare e il basic income, il concetto di base rimane grossomodo invariato: qualcuno deve darti quattrini perché il tuo lavoro non serve più. Il riferimento è sempre alla percentuale più consistente di lavoro salariato, ossia il manifatturiero e il logistico. Rimangono fuori il lavoro cognitivo e quello agricolo: quest’ultimo è quello che maggiormente fa uso di manodopera irregolare, mentre il primo da anni soggiace sulla precarietà. Le soluzioni introdotte con i redditi di base o di cittadinanza non sono reali soluzioni, ma processi compatibili con il sistema economico nel quale siamo inseriti, le quali non arrestano il principio di crescita lineare; anzi, è proprio per permettere di consumare, che si è disposti a elargire un reddito monetario.
A questo proposito sono d’obbligo alcune precisazioni sul significato di workfare e su come questo strumento si inserisca all’interno del tessuto socio-economico, non come supporto o sostegno al reddito individuale o familiare, ma come strumento che determina il comportamento individuale. Il workfare si estrinseca in un insieme di obblighi comportamentali e indirizzi all’acquisto. Chi è assoggettato al sistema deve attenersi a un insieme di obblighi e sottostare ad alcuni controlli e ciò che percepisce non può essere speso in un acquisto libero i prodotti di qualsivoglia natura.
Questo stride in parte con la retorica della libertà degli individui di poter spendere liberamente il proprio denaro, mantra tanto caro alle scuole neoliberiste, ma è coerente con una visione paternalistica dello Stato, il quale ti sta elargendo una certa somma, ma ti controlla rispetto a quel che puoi comprare. Il sistema del workfare si estrinseca anche nell’obbligo di accettare le proposte di lavoro che ti vengono fatte e nel prestare lavoro volontario per la collettività. Se a uno sguardo disattento, magari supino alla dichiarazione retorica che il sussidio non deve creare sfaticati e scansafatiche, ciò può sembrare legittimo e socialmente stimolante ma, a uno sguardo un po’ più attento, alcune contraddizioni emergono.
Una prima contraddizione risiede nell’essere costretto ad accettare un lavoro (potendo rifiutare due proposte) non solo per una questione di attitudine lavorativa, ma semplicemente per la ricattabilità insita nel meccanismo: se vieni licenziato comincia un periodo di osservazione per capire se sei un soggetto meritevole del sussidio mentre per chi licenzia, nella sostanza, non succede quasi nulla. In pratica, chi assume attraverso i canali del workfare ha dei vantaggi economici incamerando alcune mensilità del sussidio destinate al lavoratore che rigirerà a quest’ultimo. Ma oltre alla convenienza di non pagare alcune mensilità, il datore di lavoro ha il coltello dalla parte del manico dal momento che, se licenzia, sarà il lavoratore a doversi discolpare e dimostrare di essere una persona ossequiosa e ligia al dovere. Per quanto riguarda le ore da dedicare obbligatoriamente a lavori di pubblica utilità – circa 8 a settimana quelle previste dal sistema italiano – finiscono per essere lavori per conto dell’ente comunale o di aziende che operano su servizi di rilevanza comunale, quindi si può immaginare che si possano passare due turni da 4 ore a falciare prati o potare siepi, oppure assorbiti come operatori base nel terzo settore. Il problema è che se, da un lato, può sembrare lecito e razionale ripagare in qualche modo la società per il supporto economico, dall’altro, chi gestisce questo tesoretto di forza lavoro “già pagata” si ritrova a poter svolgere più lavori senza aumento di costi. Questo tipo di razionalità comincia a essere assai poco indirizzata verso qualcosa di socialmente utile.
Per quanto concerne invece in basic income, o reddito universale, se da un lato elimina la retorica lavorista e meritocratica, in quanto fisso mensile per tutti, ricchi e poveri, uomini e donne, singoli e famiglia (quindi cumulabile), dall’altro, apre l’interrogativo circa la provenienza di questo salario universale. Uno dei principali sostenitori del basic income è il professor van Parijs il quale quantifica il reddito universale come percentuale sul PIL nazionale (dal 15 al 25%) divisa per tutta la popolazione residente maggiore di 18 anni. L’esborso dovrebbe finanziarsi con l’eliminazione di tutti gli altri sussidi, comprese le pensioni. Tralasciando l’effettiva fattibilità di questo strumento, si parla per l’Italia di circa 350 euro al mese con un prelievo del 15% del PIL fino ad arrivare a circa 500 euro con un prelievo del 25%.
Il che vuol dire, avendo legato il PIL al reddito, che maggiore è il PIL maggiore è il reddito universale. Le implicazioni sono assai semplici: chi contesterà la crescita del PIL per ottenere la quale si è disposti ad esempio a svendere pezzi di territorio all’imprenditoria selvaggia o a intraprendere campagne militari per mantenere alta la produttività e accaparrarsi risorse offshore? Ma consideriamo un’altra via per finanziare il reddito universale: immaginiamo una Tobin Tax, quindi un prelievo di qualche centesimo percentuale sulle transazioni del mercato azionario che sostenga l’esborso statale. Ebbene in questo caso sarà difficile poi convincere le persone che la speculazione finanziaria genera crisi sempre più ampie dal momento che più si specula, più denari entrano nelle tasche di tutti. La crescita lineare indefinita non sarà più un mantra, ma una solida realtà da mantenere a tutti i costi.
Legare PIL e transazioni finanziarie direttamente con il benessere materiale delle persone sarebbe catastrofico dal momento che siamo pienamente inseriti in un sistema che induce bisogni inutili sempre più costosi. Senza contare che la crescita di una parte di mondo può avvenire solo a scapito di qualche altra. Il che vuol dire innescare una corsa all’accaparramento di ogni singola risorsa sulla quale poter speculare e non ci si riferisce qui alle sole risorse minerarie, ma all’acqua e alla terra, elementi scarsi, ma dei quali non si può fare a meno per nutrirsi e vivere. Probabilmente nella visione apocalittica di popoli che sostengono la diretta ridistribuzione della ricchezza, proveniente dalla crescita economica indefinita e dalle transazioni finanziarie e azionarie, l’espansionismo economico sarà sostenuto come l’unica realtà possibile, tanto quanto lo è attualmente il pensiero neoliberista.
La redazione di Malanova