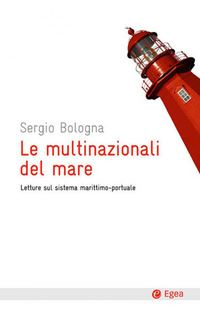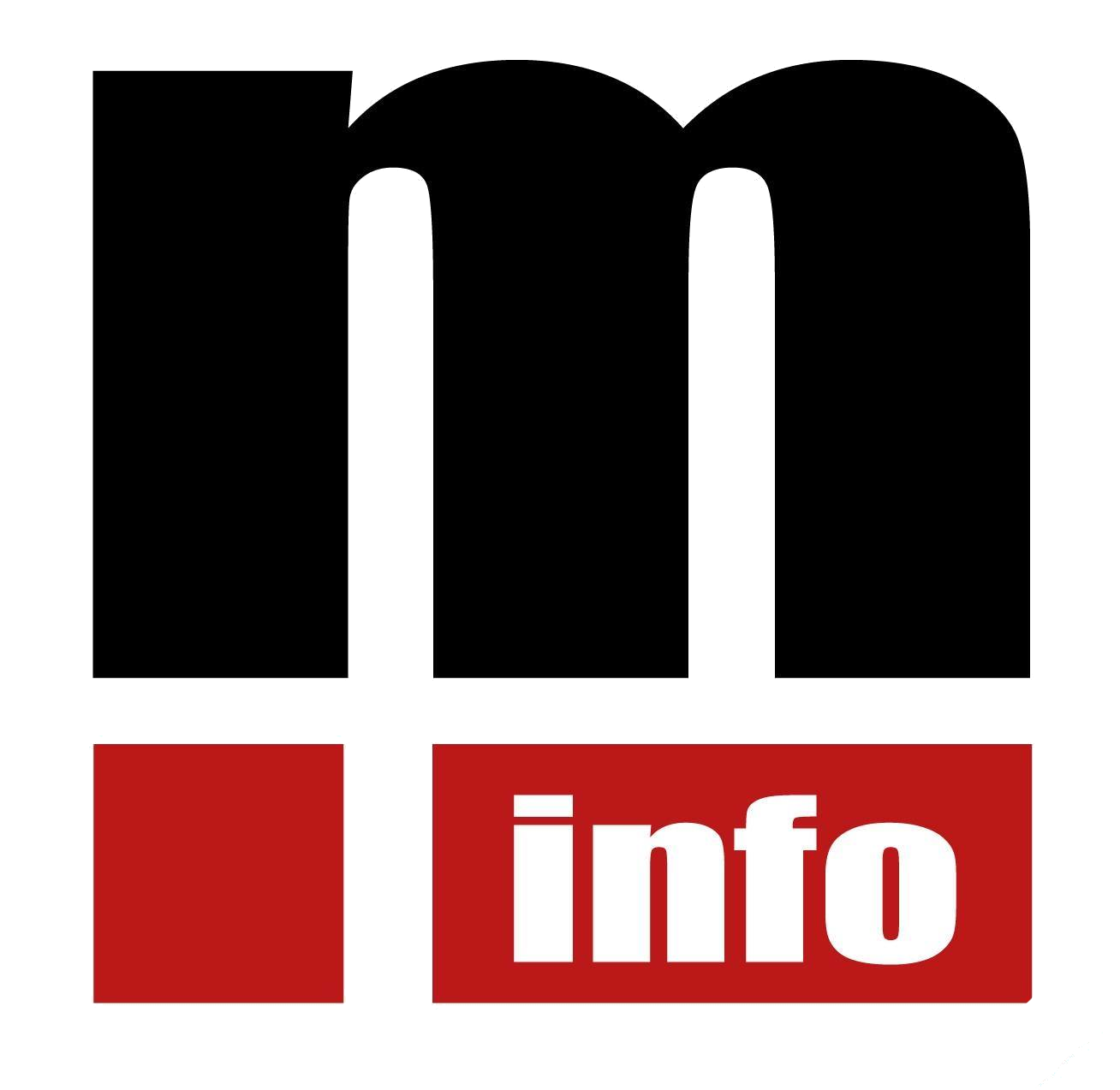Sergio Bologna nel suo libro “Le multinazionali del mare. Letture sul sistema marittimo-portuale” analizza lo sviluppo storico dei porti che sono un ecosistema economico e logistico che interessa la movimentazione di beni e servizi che interessano sia l’apparato industriale e commerciale che i consumatori finali. Il porto è un nodo fondamentale nella rete degli scambi internazionali: il “porto” al maschile diventa, declinato al femminile, una “porta” tra economie locali e mercati mondiali.
In effetti, l’immane mole di merci nel mercato internazionale vengono movimentate principalmente attraverso quattro modalità: marittima, stradale, ferroviaria e aerea. Circa l’80-90% delle merci (secondo il peso) o circa il 70% (secondo il valore), raggiunge i mercati via mare. La nave è un mezzo fondamentale per gli scambi intercontinentali e transoceanici capace di movimentare un’enorme quantità di beni. Le navi più grandi oggi disponibili possono contenere 24mila container (altra innovazione fondamentale nella tematica), quanto un ipotetico treno merci lungo 44 miglia. I container possono trasportare di tutto (alimentari, medicine, autoveicoli, macchinari pesanti, ecc.), anche materiale liquido (soprattutto petrolio e derivati). Cina e Asia costituiscono il baricentro dei trasporti marittimi. Il primo porto mondiale per movimentazione container è Shanghai e molti altri porti cinesi compaiano nella classifica dei primi 10 al mondo. Il primo porto non asiatico è in Europa (Rotterdam, al 10° posto); anche Anversa e Amburgo figurano nei primi 20. Tra questi compare un solo porto negli USA (Los Angeles, 17°).
Il porto di Gioia Tauro in Calabria, è il primo porto italiano per traffico merci e l’ottavo in Europa, situato strategicamente vicino alla rotta oriente-occidente che si estende dallo Stretto di Gibilterra al Canale di Suez; è principalmente un centro di trasbordo, collegando le reti globali e regionali che attraversano il Mediterraneo.
La teoria distingue tra porto industriale e porto commerciale. Il primo è legato a produzioni locali, dove le merci sono destinate a trasformazione o consumo immediato, mentre il secondo risponde alla domanda dell’Hinterland, il territorio retrostante, con merci gestite attraverso operazioni logistiche complesse che interessano il trasporto, lo stoccaggio o il mantenimento della famosa “catena del freddo” per i prodotti alimentari. Il porto è un sistema economico autonomo, non una semplice interfaccia tra terra e mare. La storia evolutiva di questi snodi logistici è strettamente connessa alle evoluzioni della storia economica globale che è evoluta da secoli di autarchia e nazionalismo e dalla logica dei dazi fino a giungere alla liberalizzazione radicale dei traffici della globalizzazione economica e a ritornare, seguendo l’evoluzione delle politiche americane con la presidenza Trump, a nuove politiche di tassazione. Il passaggio dalla navigazione a vela a quella a vapore con i suoi immensi investimenti ha reso più facile la movimentazione di merci da un capo all’altro del mondo. L’introduzione delle portacontainer con gru di bordo, abbinate a una flotta di camion con pianali, furono un’altra evoluzione del porto che coincise con il passaggio dal modello fordista a quello postfordista. Inoltre, il testo di Sergio Bologna affronta il tema dei processi di privatizzazione dei porti e dei servizi logistici con la precarizzazione del lavoro portuale.
Dall’analisi delle difficoltà delle operazioni di carico e scarico partì l’idea di un’unità standardizzata in grado di passare da un mezzo di trasporto all’altro con minori sforzi. L’introduzione del container ha segnato una rivoluzione radicale: semplificazione delle operazioni portuali, standardizzazione delle unità di carico e nascita della logistica intermodale. La prima nave appositamente progettata per il trasporto container, la Clifford J. Rogers, entrò in servizio nel 1955 ma fu solo negli anni ‘60 che il sistema containerizzato decollò veramente, grazie alla standardizzazione delle dimensioni (20 piedi, TEU) e alla creazione di terminal dedicati. Il porto diventa così un hub industrializzato e automatizzato, basato su software gestionali come SPARCS ed EXPRESS, capaci di pianificare operazioni, gestire flussi documentali e turnazioni del personale.
Dal 2006, con l’avvento di mega-navi come la Emma Maersk, il gigantismo navale ha posto sfide logistiche e infrastrutturali. Se da un lato aumenta l’efficienza a bordo, dall’altro comporta costi crescenti per i terminal, con lavori importanti che interessano fondali, gru, piazzali e retroporti. Le navi diventano veri e propri asset finanziari, scambiati più per logiche speculative che per esigenze operative, come denuncia la formula “trading ships not cargo”.
Il futuro dello shipping dovrà integrarsi in catene logistiche più trasparenti, automatizzate e sostenibili. Le mega-navi riducono la flessibilità e aumentano i costi di transhipment. Sergio Bologna e altri studiosi come Stopford prevedono un ridimensionamento del gigantismo, con un ritorno alla centralità della connettività, dell’intermodalità e della resilienza.
Bisognerà anche fare i conti con gli sviluppi della guerra commerciale oggi in corso tra gli USA ed il resto del mondo.
Link per l’acquisto del libro: https://www.egeaeditore.it/ita/prodotti/management/MULTINAZIONALI_DEL_MARE_LE.aspx